Live Aid: 13 luglio 1985, la musica, sul palco
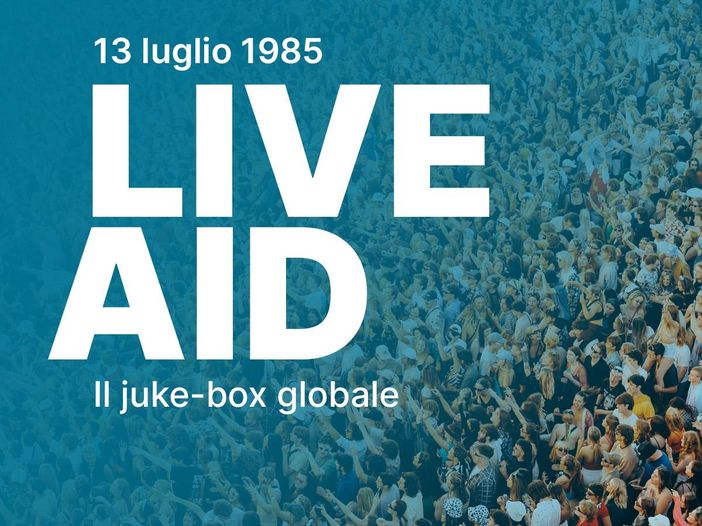
Tutti hanno ricevuto da Geldof una consegna precisa: suonate solo le hit. Quasi tutti la rispettano. Chi sgarra, come Adam Ant, che porta il nuovo singolo, si condanna da solo. Gli arrangiamenti sono quelli dei dischi, in pochi si prendono il rischio di reinventare. Al più, allungano. Chi ha dimestichezza con gli stadi capisce che servono pezzi upbeat, che arrivino subito al climax, e una band che suoni compatta. Chi non lo capisce — o non ha la voce di Sting e la presenza carismatica di Sting, in completo di lino bianco come appena uscito da una clinica ayurvedica — si perde nei grandi spazi. Phil Collins, che fa il bis tra Londra e Philadelphia, e sembra più un onesto idraulico invecchiato precocemente, si limita a due pezzi piano e voce, togliendo il tappeto Roland e il drum break che tutti aspettano per “In the Air Tonight”, e nessuno si ricorda la sua esibizione.
Il suono fa la differenza: Londra meglio di Philadelphia, che tra sibili e un impasto sui medi ha per tutto lo show la qualità di una demo. Ma anche Wembley trova il suo suono solo a partire dagli U2, oltre cinque ore dopo l’inizio. Un lunghissimo warm up di esibizioni per lo più modeste.
E poi ci sono i mezzi disastri. I Led Zeppelin con Page che sbava e fa fatica a reggersi in piedi, Plant che non è sufficientemente in forma per prendere le note alte, mentre Tony Thompson picchia come se suonasse per i Power Station, e Phil Collins stenta a capire cosa deve fare. Simon Le Bon che stecca “A View to a Kill”. Keith Richards e Ronnie Wood ubriachi.
In sintesi, dal punto di vista musicale, il contrario di Monterey e Woodstock. Scelte conservatrici, in parte reazionarie. Philadelphia senza nulla da ricordare davvero. Artisti trentacinquenni-quarantenni che tornano sul palco in un mondo che non è più il loro, e quando ancora fare musica pop significa essere giovani. Qualcosa cambierà proprio con il Live Aid, e molti di loro il palco non lo lasceranno più.
Tutti suonano per un pubblico fatto quasi esclusivamente da ragazzi e ragazze che conoscono i pezzi nuovi e magari non hanno mai sentito “Stairway to Heaven”. Ma ci sono alcune, poche, esibizioni davvero memorabili.
U2 – Wembley, ore 17.20
In assenza di Limahl, ci pensa Bono a portare il mullet sul palco del Live Aid con il suo look a metà strada tra Johnny Cash e un tardo new romantic. A Wembley, gli U2 ci arrivano carichi, anche se un po’ incerti. Hanno tre canzoni. Cominciano con “Sunday Bloody Sunday”, che incendia subito il pubblico. Poi parte “Bad”, una canzone senza un vero e proprio inciso, con la chitarra e la sezione ritmica che sembrano fare la prova generale di “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, che arriverà un paio d’anni dopo. Quando la canzone sembra sul punto di spegnersi, Bono capisce che la connessione con il pubblico non è ancora quella che vorrebbe. In prima fila, una ragazza è schiacciata dalla folla. Tenta di avvisare la sicurezza, ma non lo ascoltano. Allora salta giù dal palco e scompare per qualche secondo dal campo visivo, anche quello dei suoi compagni, che continuano a suonare senza sapere dove sia finito. Poi le telecamere lo ritrovano: sta abbracciando la ragazza, Kal Khalique, che in realtà era lì per vedere i Wham!. La stringe, ballano per un istante, le bacia la fronte. E intanto il mondo li guarda.
All’ottavo minuto la canzone riparte, disordinata e ipnotica, attraversata da frammenti di Lou Reed e dei Rolling Stones, a cercare un nuovo varco per mantenere viva la connessione speciale che si è creata con lo stadio e con chi è a casa. Si allunga, il tempo finisce, e “Pride (In the Name of Love)” non verrà mai suonata. Quando scendono dal palco sono convinti di aver sbagliato tutto, di aver sprecato l’occasione. In realtà, è il contrario: in quei quattordici minuti un po’ sbilenchi, teatrali, imprevisti, si sono trasformati in una band da stadio, una presenza globale. Da lì in poi, tutto sarà diverso. Tutti i loro dischi rientreranno in classifica, e quelli futuri li porteranno nello stardom. Finiscono gli U2 post rock e nasce Bono messia. Fuori misura, fuori copione, ma impossibile da dimenticare.
Queen – Wembley, ore 18.44
Non dovevano nemmeno esserci. Nessuno li aveva invitati per il singolo di Natale, e per un po’ sembrò che non li volessero proprio. Per Bob Geldof sono superati, hanno da tempo raggiunto il loro picco. Ma a un certo punto qualcosa cambia, e quando tocca a loro, il sole è ancora alto su Wembley e Freddie Mercury sale sul palco così com’è uscito di casa: jeans Wrangler Cowboy Cut sbiaditi, canottiera bianca, cintura borchiata, un bracciale a stringere il bicipite destro, le sue Adidas preferite, e una vodka tonic scolata tutta d’un fiato.
Non è la prima volta che suonano in uno stadio, ma è la prima in cui sanno che si giocano tutto. La band è stanca, consapevole di essere fuori moda. Hanno pensato seriamente di sciogliersi. Eppure, in quel pomeriggio d’estate, trovano un modo per rientrare nel mondo. Hanno provato per una settimana intera, al chiuso di un teatro su Euston Road, mentre gli altri si affidavano all’improvvisazione. E hanno un tecnico, Trip Khalaf, che poco prima di cominciare tocca di nascosto i limiter del suono, quel tanto che basta per farli suonare più forti di tutti. È come se da bootleg si passasse a un CD.
Freddie Mercury canta con il mal di gola, ma mostra da subito tutto il repertorio dell’entertainer consumato e perennemente sopra le righe, più Liza Minnelli che mai. Quando parte “Radio Ga Ga”, le mani di settantaduemila persone si alzano all’unisono, a replicare il doppio battito delle cinquecento comparse del video di David Mallet dell’anno prima. Non è solo il pubblico: è lo stadio stesso, il suo prato, le sue mura, le sue torri, che partecipa allo show. È il momento esatto in cui il Live Aid smette di essere un concerto e diventa un’icona: il suono della batteria e del synth di una canzone che probabilmente nessuno metterebbe tra i loro venti pezzi migliori sublima alla perfezione lo spirito del tempo. Chi era a Wembley, ma anche chi lo ha visto in televisione, non può dimenticarlo: è un atto di comunione, una celebrazione pagana. L’essere parte di un tutto infinitamente più grande. Quattro minuti scarsi, e finalmente il Live Aid che tutti ricordano ha il suo inizio. Ma in un certo senso è come se finisse. Nessun effetto speciale, nessuna luce propria, niente fumo. Solo quattro uomini, venti minuti appena, e un medley pressoché perfetto di pezzi di successo. La luce del sole che sta per tramontare splende su Wembley come solo un grande coreografo avrebbe saputo organizzare.
Da quel giorno in poi, la band capirà definitivamente di essere qualcosa che va oltre le sue parti. Ma il loro momento migliore è già alle spalle. Anche se nessuno, nemmeno loro, può saperlo.
David Bowie – Wembley, ore 19.22
Nonostante la dubbia riuscita di “Tonight”, Bowie è forse il singolo nome più importante nella scaletta inglese. Superstar assoluta, ha attraversato i Settanta da sperimentatore ed è passato all’incasso con “Let’s Dance” solo due anni prima del Live Aid. Per queste ragioni, oltre che per l’innegabile capacità di gestire uno stadio dimostrata con il Serious Moonlight Tour, Geldof pensa per lui a un doppio turno. L’idea iniziale è un duetto in diretta con Mick Jagger: uno a Londra, l’altro a Philadelphia, con i satelliti a fare da ponte. Oppure, ancora meglio, uno nello spazio e uno sulla Terra. Ma la NASA — guarda un po’ — non concede lo shuttle, e anche i collegamenti transatlantici sembrano inaffidabili. Finisce che Bowie e Jagger si ritrovano nei Docklands a registrare il video di “Dancing in the Street”, cover di un pezzo di Martha and The Vandellas, faccia a faccia, in un’atmosfera un po’ goffa, un po’ omoerotica, con Bowie che si dice soddisfatto al primo ciak e Jagger che invece vuole rifare tutto. Nonostante questo, il singolo — completamente dimenticabile — raggiunge il numero uno in classifica e ci resta per quattro settimane. Ma poi c’è il vero live.
Bowie è nel mezzo delle riprese di “Labyrinth” e non si esibisce dal vivo da un po’. I suoi musicisti abituali sono in giro per altri progetti. Mette insieme in fretta una band giovane, inglese, fatta di nomi nuovi: tra gli altri, Neil Conti dei Prefab Sprout alla batteria, Kevin Armstrong alla chitarra, Thomas Dolby – il più brillante di tutti – ai synth. In tre serate di prove in uno studio a West Kensington, cambia idea più volte sulla scaletta. All’inizio vuole suonare il suo singolo del momento, “Loving the Alien”, ma si accorge presto che non è il caso di promuovere nulla. Questo è il Live Aid, e serve altro: serve energia, serve riconoscibilità. Alla fine sceglie quattro pezzi: “TVC15”, “Modern Love”, “Rebel Rebel” e “Heroes”. Quest’ultima è forse il momento più epico della giornata. Non tanto per l’arrangiamento, che accelera e alleggerisce la versione originale, né per il pathos, più pop che solenne. Ma per come Bowie riesce a trasformarla in un inno da stadio senza svuotarla. Prima di partire, è l’unico artista a presentare uno a uno i musicisti, lasciando per ultimo proprio lui, “the very brilliant Thomas Dolby”, che nei synth riassume tutto l’universo sonoro di Eno, Fripp e Bowie messi insieme.
Bowie è quello ripulito e pastello di “Let’s Dance”, con un abito di dieci anni prima, periodo “Young Americans”. È l’unico a usare una cravatta, con il nodo aggiustato da Lady Diana in persona nel backstage. I capelli un po’ meno biondi, i denti ancora quelli originali. E in “Heroes” è davvero al suo meglio: alterna singing e shouting, scende dal palco, si avvicina al pubblico con una self confidence unica e lo ingaggia in una serie di call & response, mentre la canzone sembra finire e poi riparte.
Finale
Il finale che resta nella memoria è quello di Wembley, con Paul McCartney seduto al pianoforte che intona “Let It Be”. Ha da poco compiuto quarantatré anni, ma sembra ancora un ragazzino. È la sua prima esibizione live dopo la morte di John Lennon. Non suona dal vivo con una band da sei anni: la sua pausa più lunga dai tempi in cui i Beatles smettono di fare concerti, nel 1966. Fino a un attimo prima, si parla di una parziale reunion — George Harrison, Ringo Starr, Julian Lennon al piano —. Ma appena la voce si diffonde, l’idea svanisce.
È oramai notte, Paul deve sentirsi solo, non è mai stato su un palco senza una band e con un pianoforte, per di più è a Wembley e il mondo lo guarda. Ciliegina sulla torta, il suo microfono smette di funzionare e riprenderà a farlo solo un paio di minuti dopo: i tecnici dei Queen, appena usciti, hanno staccato per errore i suoi spinotti. Quando la voce arriva, il pubblico applaude, McCartney riprende confidenza, chiede al pubblico di cantare l’inciso. Un paio di minuti ancora e viene raggiunto sul palco da Bob Geldof, David Bowie, Alison Moyet e Pete Townshend, che sbagliano subito l’ingresso nel brano intonando il ritornello quando McCartney è ripartito con la strofa.
Questo insieme di piccoli incidenti, dopo una giornata trascorsa senza grandi imprevisti, ricorda a tutti la rischiosità di un evento del genere e del modo in cui è stato preparato: senza prove, senza soundcheck, senza tempo. La marea arancione del pubblico di Wembley e la gente a casa avvertono tutta la dolcezza e l’umanità di questo momento e, cantando una canzone di quindici anni prima, mettono la parola fine alla versione europea di un concerto che sarà a lungo ricordato e che non avrà un vero erede.
Che a chiudere tutto sia una canzone dei Beatles testimonia la primogenitura britannica di questi sette mesi di attività frenetiche per riportare la musica al centro di un problema sociale, come per “Concert For Bangladesh”, “Concert For Kampuchea” e “No Nukes”, solo con una scala e un’ambizione immensamente più grandi.
Legacy
Il Live Aid arriva nel momento giusto. Per la musica, per l’industria, per chi ascolta. È la vetrina perfetta per un nuovo formato che si sta appena affermando: il compact disc. Ma non è solo una questione di supporti. Le vendite esplodono, le reputazioni cambiano. Gli U2 salgono al vertice del pop mondiale, i Queen tornano a essere, di colpo, la miglior rock band del pianeta. L’intero settore respira. L’effetto è corroborante, persino per chi non ha suonato.
La beneficenza diventa spettacolo, e lo spettacolo una cosa seria. Qualcuno comincia a parlare di una nuova Woodstock, ma senza l’innocenza, né l’utopia. Più che controcultura, è il trionfo del pop aziendale. Con i reali in tribuna e un mondo a guardare.
La prima metà degli anni Ottanta, con i trend che sembravano nascere quasi ogni giorno — new pop, gothic, new wave, synth pop, indie e altro ancora — finisce quasi all’improvviso. Certo, ci saranno “Psychocandy” dei Jesus and The Mary Chain da lì a poco, “The Queen Is Dead” degli Smiths l’anno dopo, “Sign o’ the Times” di Prince nel 1987. Ma è come se il pop e i suoni diventassero ancora più semplici, più dominanti, più plasticosi.
Qualcosa cambia anche nel modo in cui le popstar vengono percepite. I Duran Duran diranno che è lì, in quel giorno, che hanno smesso di essere solo musicisti e cominciato a sentire addosso il peso dell’esempio. È l’inizio del culto della celebrità moderna. I giornali, soprattutto quelli inglesi, iniziano a vendere di più con i gossip che con le recensioni.
La musica diventa intrattenimento, e chi la fa deve funzionare anche fuori dal palco. Non è necessariamente un male, ma da quel momento in poi non si tornerà più indietro.
13 luglio 1985, poco prima di mezzanotte
Quando spengo la televisione dopo quasi undici ore di musica, ho già dimenticato tutta la prima parte di Wembley, con il suono impastato e i gruppi che si perdevano nell’immensità dello stadio. Ho anche elaborato la parziale delusione per gli Style Council, da cui mi aspettavo di più (Paul Weller resta comunque il più stiloso della giornata, con i jeans bianchi e la felpa rossa). Sto accettando il fatto che non c’è stato quasi nessuno degli artisti che hanno accompagnato i miei ascolti nei dodici mesi precedenti. Niente Springsteen, niente Prince, e soprattutto niente Smiths, nonostante il numero uno di "Meat Is Murder" uscito solo pochi mesi prima. Tanto meno tutti quei gruppetti pop che si sarebbero trovati meglio in un club di Glasgow. Per non parlare di David Sylvian. Mi sono consolato con un grande David Bowie, e con il finale di Paul McCartney. Philadelphia l’ho trovata irrilevante. Non fremevo per la ricostituzione di Crosby, Stills, Nash & Young, né per i Black Sabbath, e devo essere sincero: nemmeno per i Led Zeppelin. La musica “vecchia” che ascolto arriva quasi tutta dai Sessanta.
Non faccio paragoni con Woodstock, di cui so ancora poco, ma so che dal giorno dopo cominceranno discussioni infinite con Francesco: sulla rilevanza culturale dell’evento, su chi c’era e chi no, su tutti i resuscitati.
È appena uscito "Steve McQueen" dei Prefab Sprout e sono convinto che gli anni Ottanta che ho conosciuto fino a quel momento — fatti di musica pop alternativa che cambia ogni sei mesi e riesce a entrare in classifica — siano destinati a continuare. Invece no. Il Live Aid segna davvero la fine degli anni Ottanta che mi piacevano, quelli che ancora oggi citiamo, che ricordiamo. I gruppi, gli artisti rimasti nell’immaginario hanno avuto quasi tutti il loro picco tra l’82 e l’84. Poi si è spenta la luce. Le major, i soldi, i suoni, una generale tendenza alla restaurazione.
Dove prima il pop era fatto da Aztec Camera, China Crisis, Pale Fountains — capaci di affacciarsi nelle zone medie delle charts — dopo sarà rappresentato da Go West o Johnny Hates Jazz. Non esattamente la stessa cosa. Dove prima c’erano chitarre acustiche e synth analogici suonati con gusto, dopo sarà tutto un fiorire di bassi synth, sax, batterie sempre più plastificate. Il pop interessante si ritirerà nelle indie charts. Un’epoca è finita. Ma non me ne accorgo subito. Ci metterò un po’. Sto salutando un amico quasi per l’ultima volta. (A.L.)
