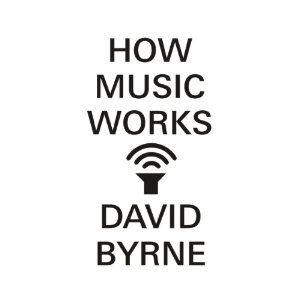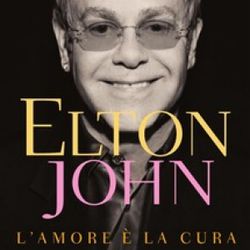© 2025 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini
Rockol
- Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
- Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
- Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
- Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
- È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.
Segnalazioni
Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.