Quando la musica diventò liquida, prima ancora del digitale
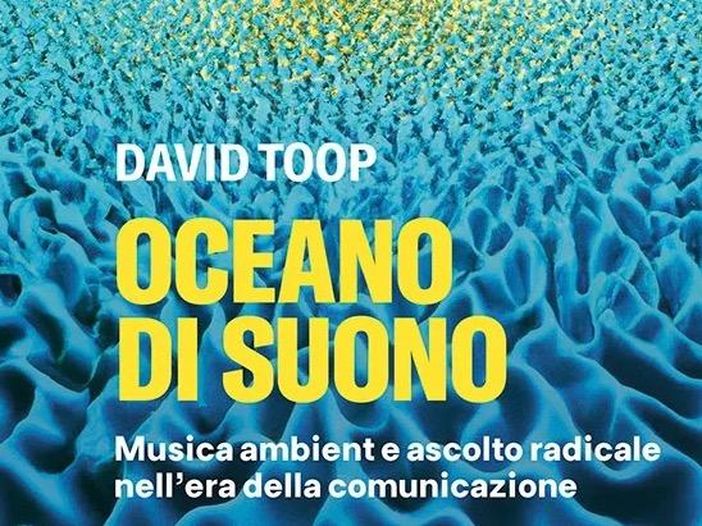
Nella seconda metà degli anni '90 trovare libri musicali che non fossero biografie, storie del rock o raccolte (illegali) di testi era abbastanza complesso, soprattutto in Italia. La saggistica era limitata, la musica pop (o la popular music, all'inglese) era praticamente assente dalle università. Solo qualche studioso pioniere provava a leggerme l'evoluzione e/o i mutamenti con un respiro più ampio. In italia, dagli anni '80, ci fu il meritorio lavoro di una Costa & Nolan, che in mezzo a saggistica di diversa natura - italiana e straniera - pubblicò anche in italia il lavoro di studiosi come Dick Hebdige ("Sottoculture") e Iain Chambers. E David Toop: nel '95 uscìper la casa editrice genovese la prima edizione di "Oceano di suono" - allora sottotitolato "Discorsi eterei, ambient sound e mondi immaginari". La casa editrice torinese ADD Editore fa un lavoro altrettanto meritorio e lo ripubblica in Italiano in una versione aggiornata, nella traduzione di Michele Piumini, con un'introduzione di Valerio Mattioli.
Mattioli, che proprio alle origini della musica elettronica inglese ha dedicato recentemente "Ex machina", lo definisce subito senza mezzi termini "uno dei libri di musica più importanti mai scritti". Toop si occupa di un momento specifico, le intersezioni tra la nascita della musica ambient con mutamenti tecnologici e delle forme di consumo, con una visione che ha anticipato sviluppi successivo non solo musicali ma anche sociali. Usa una metafora che poi sarebbe diventata molto ma molto popolare, anche applicata alla musica: l'acqua, la versione sonora della famosa lettura della società liquida di Zygmunt Bauman.
"Oceano di suono", ricorda Mattioli, viene scritto nell'anno di uscita di album fondamentali di Aphex Twin, degli Orb e di Brian Eno, ma soprattutto nel periodo in cui, negli stati si formava la “bolla dot.com”. Toop analizza la musica ambient come un movimento culturale, come una forma di "ascolto radicale nell'era della comunicazione musicale", come recita il sottotitolo dell'edizione 2018, quella che oggi viene ripubblicata.
Toop non è un accademico ma una via di mezzo tra un giornalista e un narratore che usa anche la sua esperienza da musicista: la sua analisi procede per racconti, aneddoti, intuizioni. Una lettura non sempre lineare, ma piacevole e ancora oggi iperstimolante. Come scrive Mattioli: "Oceano di suono è tuttora un documento cruciale per chiunque, pur non interessato alla musica, voglia com-prendere le origini di quella Civiltà della Rete inizialmente sospinta dal lento arrancare di un modem a 56k e dalla sigla di avvio di sistemi antidiluviani come Windows 95 (a tal proposito: sigla composta indovinate da chi? Ma dall’onnipresente Brian Eno, che domande)", scrive Mattioli.
Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo l'introduzione all'edizione 2018, firmata da David Toop. Qua invece la scheda del libro dell'editore
David Toop - nota dell’autore alla nuova edizione di "Oceano di Suono"
Il veicolo migliore, al momento giusto, per idee che stavo elaborando sin dai tardi anni Sessanta: ecco cos’era Oceano di suono. Oggi lo vedo come un Cavallo di Troia, la musica ambient dei primi Novanta come pretesto per un discorso più ampio sulla musica sperimentale novecentesca di ogni tipo. In realtà, era tutto molto meno calcolato. Scrissi il libro in tre o quattro mesi di lavoro febbrile, durante un periodo difficile sul piano personale. Paradossalmente, forse questa è una delle ragioni del suo relativo ottimismo. Ero ispirato da tutta la musica innovativa che emergeva nei primi Novanta, una fase in cui le barriere fra i generi sembravano sgretolarsi. Nell’aria si coglieva una netta atmosfera di sperimentalismo socioculturale che si ricollegava al tardo Ottocento, il che mi permise di trovare paralleli fra la musica elettronica contemporanea, la scena ambient e i loro precursori d’avanguardia. Ne ricavai uno stimolo per riprendere a fare musica dopo anni in cui mi ero dedicato alla critica quasi a tempo pieno, ma mi servì anche come contrappeso ai problemi personali.
Subito dopo la consegna del manoscritto quei problemi si aggravarono drasticamente, mettendomi nell’insolita condizione di dover lottare per la sopravvivenza emotiva proprio nel momento in cui tutte le mie idee degli ultimi venticinque anni si erano realizzate. Il libro ebbe un successo sorprendente, e ancora oggi in molti mi dicono che gli ha cambiato la vita. Il che da un lato mi gratifica, ovviamente, ma dall’altro, ipercritico e tendenzialmente scettico come sono, mi porta a rivederlo per capire cos’ha che non va. Un aspetto che mi colpisce è la visione utopica di quelli che nel 1995 erano sviluppi nuovissimi: l’avvento di Internet con tutte le sue implicazioni per la globalizzazione, le comunicazioni e la diffusione della cultura. Che l’effetto su produzione e distribuzione musicale sarebbe stato traumatico era evidente, ma con il senno di poi, non aver previsto un futuro assai più oscuro per il web – dominato da interessi aziendali, hate speech, pornografia estrema e sciocchezze assortite, senza contare lo sterminio dei media esistenti – era stato un grave errore.
Lo stesso titolo – Oceano di suono – fu criticato per i suoi richiami New Age. Questo mi infastidisce meno. In origine avevo pensato a Aether Talk (“discorsi eterei”, un altro riferimento all’ascesa del World Wide Web), ma come sottolineato da Pete Ayrton, fondatore della casa editrice Serpent’s Tail, il pubblico rischiava di sbagliare a scriverlo e non capirne il senso. Mi resi conto che serviva un titolo più accattivante. La domanda è: l’oceano di suono era una metafora adatta a rendere la mia nozione di musica? A interessarmi è la rete dei rapporti, quelle connessioni labirintiche che uniscono gli argomenti più improbabili senza distinzioni di genere, epoca, provenienza geografica, classe sociale, etnia, linguaggio, età, orientamento sessuale e tutti gli altri fattori culturali e demografici utilizzati per suddividere la musica (spesso per ragioni commerciali) in categorie ben definite.
Forse avrei fatto meglio a orientarmi sull’ecologia vegetale o animale, non so, ma l’immagine dell’oceano, associata com’è a forme d’onda, fluidità, trasparenza, profondità e vastità, mi consentiva di scrivere di musica in maniera diversa. Quel che so è che sin da bambino ero attratto dalla musica, dai suoni e dalle esperienze d’ascolto, non in quanto affermazioni identitarie o messaggi rivolti a una particolare fascia demografica. Nei primi anni Ottanta ero co-direttore di una rivista chiamata «Collusion».
La nostra linea era occuparci di qualunque musica ci interessasse, a prescindere da quanto fosse moderna, nuova o “importante”. Qualche anno dopo scrivevo una rubrica fissa sul mensile «The Face», ben sapendo di poter usare le mille parole a mia disposizione per giocare con, e persino combattere contro, la passione della rivista per le fashion tribes e i loro gusti musicali.
Oceano di suono poggiava su queste fondamenta, ma mi ci volle parecchio tempo – fino ai quarantacinque anni o giù di lì – per trovare il modo di declinare questo approccio errabondo nella struttura e nelle dimensioni di un libro. Lo stile di Oceano di suono si ispirava al “taglia e incolla” della videoscrittura, alle riflessioni sui link ipertestuali e agli scrittori sperimentali che mi avevano influenzato durante l’adolescenza. Sforzandomi di trovare la forma adatta, mi resi conto che potevo fare a meno della linearità per costruire una storia a partire da brevi blocchi di testo connessi a temi più ampi.
Era una sorta di improvvisazione free, un genere nel quale ero coinvolto sin dagli anni Sessanta, ma allo stesso tempo rispecchiava la musica computerizzata che facevo all’epoca e il sampling hip hop di cui avevo scritto in Rap Attack dieci anni prima.
Con il tempo, l’impressione è che questo modo di concepire la musica sia quasi diventato la norma per via degli effetti collaterali del progresso tecnologico. Le playlist sui dispositivi digitali hanno contribuito ad abbattere i confini tra i generi, mentre il file sharing illegale ha avuto la meglio sulle strategie discografiche e l’avvento di siti di video sharing come YouTube ha incoraggiato un approccio “link e click” pressoché casuale alla scoperta musicale. Simon Reynolds ha scritto un articolo molto lusinghiero, We Are All David Toop Now, titolo che, sostiene, gli è venuto in mente tutto a un tratto, come frase completa: «Se vogliamo sviscerarlo, il senso di quello slogan è che qualsiasi ragazzo con una connessione a banda larga ha accesso alla vertiginosa varietà di esperienze d’ascolto che Toop ci ha messo una vita di dedizione ossessiva ad accumulare».
Il saggio di Reynolds metteva in guardia dal “turismo stile checklist” e dal “sovraccarico frenetico”, un avvertimento che condivido. A livello personale, ricordo che la musica di metà anni Novanta mi entusiasmava come una sorta di fantascienza, presagio di uno stato di cose nel quale eravamo quasi immersi ma le cui implicazioni complete (e spesso sconfortanti) ancora ci sfuggivano.
Vale anche per oggi?
Difficile dirlo; il bello di scrivere Oceano di suono all’epoca era che al centro della prospettiva critica poteva esserci la futurologia. Oggi non è così vero, fosse solo perché abbiamo cominciato a diffidare dei futuri imprevedibili e dell’instabilità che creano quando arrivano. Ma riguardando a ventitré anni di distanza ciò che avevo scritto in un’epoca molto diversa, sono orgoglioso del libro, non tanto per lo stile quanto perché ero riuscito in un’impresa che avevo sempre ritenuto impossibile: raccogliere le mie conoscenze, idee e teorie arcane e avanguardistiche in un solo volume e presentarle a un pubblico ragionevolmente ampio. Forse non ci riuscirò più, ma nei miei particolari settori di competenza una volta può anche bastare.
