"Lateral" - At The Movies: Le Canzoni al Cinema
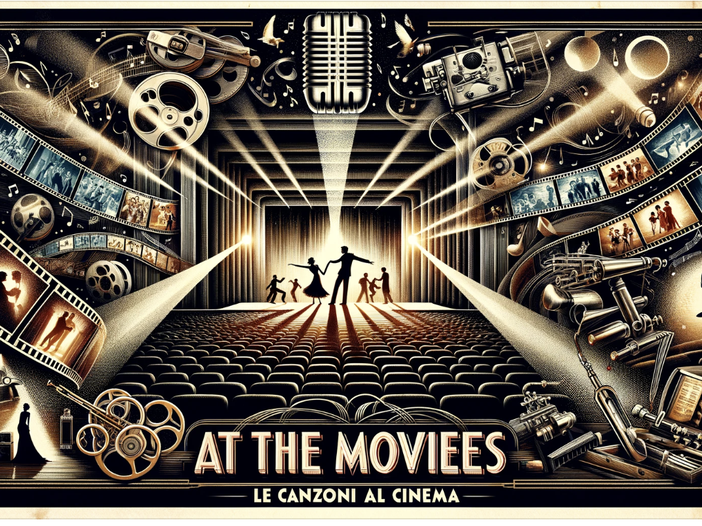
Lateral è un appuntamento periodico di Rockol per attraversare la storia della musica popolare, alta e bassa, e offrirne una vista, appunto, laterale.
§§§
Alcune delle più grandi scene della storia del cinema sono memorabili proprio perché accompagnate dalla canzone perfetta. Una relazione simbiotica tra adattamenti di musical, canzoni originali, pezzi editi famosi o da riscoprire che nasce negli anni Sessanta, matura nei Settanta e negli Ottanta, per poi esplodere definitivamente negli anni Novanta con l’approccio compilativo di Tarantino e Scorsese prima, e di Wes Anderson e Sofia Coppola poi. Da “Il Laureato” a “Quei Bravi Ragazzi”, da “Saturday Night Fever” a “Trainspotting”, da “Pulp Fiction” a “Caro Diario”, tra trailerisation ed effetto jukebox, un viaggio in tre puntate tra le canzoni e i film più belli della storia, insieme.

Seconda Parte
Schermo nero. Una voce off di uomo pronuncia alcune parole: “Non rimedi ai tuoi peccati in chiesa. Li sconti per le strade. Li sconti a casa. Il resto sono stronzate, e lo sai.” Nell’inquadratura appare un giovane che si sveglia di soprassalto, in una stanza semibuia. La poca luce è filtrata dalle veneziane della finestra. L’uomo si alza dal letto, fa qualche passo e si guarda in uno specchio appeso al muro di fronte al letto. Poi torna a sdraiarsi. Dalla strada arrivano rumori di automobili, clacson, una sirena. Mentre si sta coricando, tre veloci stacchi avvicinano sempre di più l’inquadratura, coordinandosi con le battute iniziali di una canzone. Iniziano i titoli di testa, con le immagini sgranate di un Super8 con l’uomo che scherza con gli amici a Little Italy. I ricordi di tempi felici, prima che tutto vada in pezzi. L’uomo è Harvey Keitel, la canzone è “Be My Baby” delle Ronettes, il film è “Mean Streets”, il regista Martin Scorsese. L’anno è il 1973. “Mean Streets” esce nell’anno di “American Graffiti”, ma la storia che narra è contemporanea alla sua realizzazione. Il fatto di iniziare con una canzone di dieci anni prima è una mossa rivoluzionaria, anche se il regista si dimentica di assicurarsi l’autorizzazione a utilizzare la canzone. Phil Spector, autore e produttore di “Be My Baby”, se ne accorge solo perché informato da John Lennon che fa da pacificatore evitando un’azione legale che avrebbe comportato il ritiro del film dai cinema. Gli anni Novanta sono unanimamente considerati il decennio del matrimonio definitivo tra cinema e canzoni pop, spesso di sapore vintage. Chi ne parla cita spesso Quentin Tarantino come il maestro assoluto di questa alchimia, dimenticandosi il vero padre fondatore, Martin Scorsese appunto, che comincia quasi vent’anni prima a riempire le soundtrack dei suoi film con un puzzle di brani del passato, surfando tra pop, rock e musica lirica. Scorsese mostrerà al mondo la sua capacità unica di influenzare l’atmosfera, definire il ritmo e indicare il tempo e lo spazio, solo con qualche nota. Si rivelerà il numero uno nell’utilizzare giustapposizioni uniche di immagini e musica diegetica e non diegetica per creare narrazioni a più livelli che attingono a convenzioni estetiche dei decenni precedenti, ma vengono proposte in una logica concettualmente progressista. La musica assume la stessa importanza dei dialoghi, se non un’importanza maggiore.
Passano 3 anni ed è il momento di “Taxi Driver”. Le composizioni orchestrali di Bernard Herrmann dominano la colonna sonora, ma, in una scena, Travis, il tassista paranoico interpretato da Robert De Niro stringe tra le mani una .44 Magnum mentre guarda in TV giovani coppie che ballano al suono di "Late for the Sky" di Jackson Browne. La canzone racconta del momento in cui capisci che qualcosa è cambiato, è finito per sempre, e tu sei già in ritardo per quello che arriverà dopo. Scorsese usa poco più di un minuto del brano accompagnando Travis, con un’espressione vuota nella quale si può leggere tutto o niente. Probabilmente nasce qui il “needle drop”, il momento in cui parte una canzone conosciuta che, stabilendo connessioni con la nostra memoria culturale, rende al meglio una sensazione che il pubblico non riesce a definire del tutto e che rende la scena indimenticabile.
Arriva il 1990 e Scorsese passa al livello successivo, definendo i canoni della colonna sonora compilativa e dimostrando una capacità unica di combinare suono e immagini amplificando il risultato e lasciando intatta la forza delle due parti. Per “Goodfellas”, Scorsese realizza il matrimonio più toccante seguendo una regola chiara e creando un canone utilizzato a più riprese fino ai giorni nostri: ogni canzone deve essere coeva o precedente rispetto al periodo in cui è ambientata la scena e i brani devono realizzare un commento obliquo della scena o dei personaggi. Nel film si ascoltano quarantatré canzoni che raccontano lo spirito del tempo con classici di Dean Martin, Drifters, Who e Rolling Stones. Tra i tanti momenti indimenticabili di sync perfetto tra suono e immagine, ce ne sono almeno due che vale la pena ricordare. Il primo è quello della first date tra Henry (Ray Liotta) e Karen (Lorraine Bracco). Diciassette anni dopo “Mean Streets”, Scorsese torna a Phil Spector e con “Then He Kissed Me” accompagna i due dalla strada al tavolo del club, con due minuti e cinquantanove secondi di Steadicam, in un unico piano sequenza. L’accordo con cui si apre la canzone è associato al gesto di potere con cui Henry lascia le chiavi dell’auto al valet e inizia la sua entrata regale al Copacabana evitando la coda, attraversando le cucine e dispensando mance e saluti ai cortigiani, come un buon sovrano. Scorsese sceglie di fondere la canzone con i suoni di scena, i dialoghi tra i due innamorati e con gli altri comprimari, creando un insieme che allo stesso tempo comunica eccitazione e affermazione di potere. Le parole ingenue della canzone fanno da perfetto contrappunto alle espressioni di meraviglia di Karen che vede allestito sul momento un tavolo sotto il palco, solo per loro due. Il secondo “needle drop” è la sequenza più famosa del film. Siamo tra gli archi che sostengono una strada sopraelevata e due ragazzini si avvicinano a una Cadillac rosa. La macchina da presa diventa i loro occhi e risale il cofano dell’auto per mostrare chi c’è dentro. Contemporaneamente, partono alcune note suonate a un piano, la seconda parte di “Layla” di Derek And The Dominos. I quattro minuti che seguono raccontano con le immagini e la voce fuori campo di Ray Liotta le conseguenze dell’ultimo colpo dei bravi ragazzi, la rapina alla Lufthansa, oltre 5 milioni di dollari in contanti e un altro milione in gioielli. Il successo si trasforma rapidamente in rancore, con il paranoico Robert (Jimmy) De Niro che fa ammazzare tutti. La musica dolcissima e carica di nostalgia fa da contrappunto al montaggio brutale di cadaveri e distruzione, raccontato con una calma unica, come la fine di una variante mafiosa del sogno americano. Il crepuscolo degli dei che avvolge i “bravi ragazzi” è anche quello di un’intera generazione che è vissuta nell’illimitato benessere del dopoguerra e che adesso deve affrontare uno scenario completamente diverso all’alba degli anni Settanta. La canzone è così radicata nella visione che il regista ha della sequenza che pretende sia suonata durante le riprese. Ma c’è di più. Nella memoria collettiva, “Layla” è composta da due sezioni separate e Scorsese sceglie di far partire la canzone alla fine della prima metà. Lo spettatore rimane disorientato da questa scelta che amplifica la risposta emotiva, anche grazie all’assenza del cantato. Si può anche leggere un sottotesto nella scelta della canzone, considerando la tragica fine di diversi membri del supergruppo Derek And The Dominos, con Duane Allman che muore in un incidente motociclistico l’anno dopo l’uscita del disco, Jim Gordon che si trasforma in uno schizofrenico violento e uccide la madre ed Eric Clapton che sopravvive per miracolo a dipendenze da eroina e alcol.
Altri cinque anni e la scena si sposta da New York a Las Vegas, dove con i fedeli De Niro e Pesci e la new entry Sharon Stone, Scorsese completa la sua personale trilogia sulla mafia in un film che si dispiega come una tragedia greca. Tra le canzoni che costellano la narrazione, “House Of The Rising Sun” degli Animals svolge il ruolo di “Layla” come sottofondo di una serie di esecuzioni. E arriviamo infine al 2013 quando è il turno di "Gloria" di Umberto Tozzi a completare le immagini di Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) e della sua banda che rischiano di morire dopo che il loro yacht è stato sorpreso da una tempesta. La canzone è utilizzata diegeticamente quando vengono salvati dalle autorità italiane e danno inizio ai festeggiamenti.
“Goodfellas” fa riscoprire il gusto di utilizzare canzoni del passato, che con il passare del tempo suonano sempre più vintage, ad aumentare la distanza rispetto ai suoni della contemporaneità. Mentre da Seattle si fa sempre più forte la voce del grunge, un film americano del 1990 riscopre una canzone a lungo dimenticata, già utilizzata in una prima versione per il film “Unchained”, uscito trentacinque anni prima. La versione definitiva del brano arriva dieci anni dopo, nel 1965, originariamente come lato B di un singolo dei Righteous Brothers ed è quella che caratterizza “Ghost”, quasi come un personaggio minore del film, apparendo in tre diverse occasioni. La più famosa, oggetto di innumerevoli parodie, è quella che vede Demi “Molly” Moore lavorare la ceramica, mentre il brano viene suonato da un juke box, con tutti i crepitii del vinile. “Unchained Melody” torna in classifica e arriva al numero uno delle chart inglesi. La diga è oramai aperta. Più o meno in contemporanea esce “Pretty Woman” che fa riscoprire al mondo Roy Orbison. Quattro anni ed è il turno di “Love Is All Around” dei Troggs, in questo caso nella cover dei Wet Wet Wet. E poi, ancora, “My Sharona” in “Reality Bites” e “Bohemian Rhapsody” in “Wayne’s World”. C’è spazio anche per inediti, più o meno fortunati. Non solo per i redivivi Aerosmith con la loro “I Don’t Want To Miss A Thing” in “Armageddon”, ma anche e soprattutto per il grande Elliott Smith che regala alcune delle sue canzoni a “Good Will Hunting”, tra le quali “Miss Misery” che lo porta sul palco degli Oscar dove perde contro Celine Dion. Due anni dopo, è la volta della cover di “Because” per i titoli di coda di “American Beauty”.
Nel 1992 fa il suo esordio Quentin Tarantino, il regista che forse più di tutti rappresenta nell’immaginario collettivo il compilatore per eccellenza di colonne sonore con canzoni del passato. Come Scorsese, ha una collezione personale di vinili che attinge dalla golden age della musica dei Sessanta e dei Settanta da dove prende l’ispirazione per individuare la personalità, lo spirito dei suoi film. Diversamente da Scorsese, evita quasi completamente il rock, preferendo brani pop o molto tipizzati come genere, tra il surf e il funk, dando nuova vita a canzoni dimenticate. Tarantino non usa la musica per evocare lo spirito del tempo, ma come effetto per sottolineare il progredire della storia, con scelte stilistiche spesso autorefenziali e pressoché uniche, che rendono le colonne sonore dei suoi film quasi un genere musicale a sé.
Tarantino diventa il maestro dei titoli di testa, soprattutto nei primi film. L’ingresso in slow motion dei membri della band di “Reservoir Dogs” scandito dalle note di “Little Green Bag”, il freeze frame di “Pulp Fiction” su "Miserlou" ad anticipare l’esplosione narrativa, Nancy Sinatra e “Bang Bang” per aprire “Kill Bill Vol. 2”, quasi come un’elegia funebre che segue la violenza delle prime scene. Le canzoni e le sequenze inchiodano lo spettatore alla poltrona, in attesa dell’azione, affascinato, in un turbine multisensoriale. Anche i brani meno conosciuti o trascurati con il passare del tempo sono scelti in base a suoni capaci di creare nello spettatore risonanze culturali che lo collocano istantaneamente in un tempo e in uno spazio diverso.
I needle drop si sprecano, spesso costruiti su giustapposizioni che amplificano il contenuto narrativo, come “Stuck In The Middle With You” nella scena del taglio dell’orecchio di “Reservoir Dogs”. La canzone è diegetica perché proviene da un programma radio sul canale che accompagna diverse scene del film e con la sue sonorità morbide e anni Settanta, in contraddizione con la violenza delle immagini, funziona un po’ come la “Singin’ In The Rain” cantata da Alex in “Arancia Meccanica”. Un po’ antidoto alla tensione della scena, un po’ celebrazione di un approccio distaccato e indifferente al dolore procurato ad altri. “Pulp Fiction” addirittura trabocca di momenti iconici, tra l’overdose di Mia Wallace sulle note di “Girl You’ll Be A Woman Soon” e la scena del ballo con Vincent Vega al Jack Rabbit Slim’s, accompagnata da “You Never Can Tell”.
A partire da “Kill Bill”, Tarantino cambia l’approccio alla musica, riduce il numero di canzoni del passato e inizia a utilizzare colonne sonore di altri film. Il periodo da cui attinge è lo stesso, quasi esclusivamente compreso tra il 1960 e il 1979. La scelta si concentra su contenuti che non sono ultra noti e che restituiscono allo spettatore più un senso generico di “altro”, piuttosto che un riferimento preciso al film originale. Tarantino suggerisce mondi sonori tipici del western o del giallo all’italiana, senza che la sua opera sia travolta da confronti con musiche o film troppo ingombranti. Un caso particolare è rappresentato dall’uso in “Inglorious Basterds” di “Cat People (Putting Out Fire)”, scritta da David Bowie e Giorgio Moroder. Siamo nel 1982, Bowie è nel periodo di transizione tra la RCA e la EMI e la incide negli studi di Montreaux, in Svizzera, dove incontrerà i Queen e si materializzerà la collaborazione di “Under Pressure”. La canzone, pur nel suo anacronismo rispetto alla narrazione, è semplicemente perfetta per la sequenza potente in cui Shosanna si prepara a dare inizio al suo piano per uccidere Hitler e far saltare un teatro pieno di nazisti. Pochi secondi dopo aver sentio Bowie cantare “Vedi questi occhi così verdi”, la cinepresa inquadra lo sguardo felino di Mélanie Laurent in abito rosso che fa pendant con la bandiera nazista sullo sfondo. Quando il crooning di Bowie sale di registro, la musica è in perfetto sincro con i gesti della donna che si mette il rossetto e si trucca in una modalità che, anche grazie alla musica, ricorda una cerimonia propiziatoria prima della battaglia. Per chi l’ha vista la prima volta al cinema dove i bassi della canzone fanno tremare le sedie, è impossibile dimenticarla.
La risposta europea a Scorsese e Tarantino arriva nel 1996. La scena è quella di Princess Street, Edinburgo, il regista è Danny Boyle, il film “Trainspotting”. Il risultato finale rasenta la perfezione in un cocktail che - anche a causa di alcuni rifiuti a concedere le canzoni citate dal libro di Irvine Welsh, come quelle di Bowie - miscela anni Settanta e Ottanta, la scena rave e ci aggiunge un pizzico di Brit Pop, l’ultima voce collettiva della gioventù inglese, praticamente al culmine della sua parabola quando il film viene girato. Fin dall'inquadratura iniziale, “Trainspotting” è un film frenetico, con le sneakers di Renton - interpretato da un giovane Ewan McGregor – che battono i marciapiedi della città scozzese al ritmo dei 104 bpm di "Lust For Life" di Iggy Pop, in fuga da due guardie di sicurezza, con il bottino del taccheggio che vola fuori dalle tasche. "Choose life", inizia la narrazione di Renton, introducendo un monologo sulla vacuità delle aspirazioni della classe media che diventa un instant classic. L'azione si sposta poi su una partita di calcio che introduce gli sgangherati compagni di Renton: Spud, Sick Boy, Begbie e Tommy. La scena è in continua propulsione e, in soli 60 secondi, ci dice esattamente cosa sarà il film.
Danny Boyle dimostra di avere imparato la lezione di Scorsese e Tarantino e in alcuni casi dimostra di poter superare i maestri come nella scena con “Perfect Day”. In una sequenza sfolgorante, Renton si inietta una dose di eroina recuperata dal suo spacciatore di fiducia e inizia ad affondare romanticamente nel pavimento, mentre Lou Reed canta di una giornata perfetta, bevendo sangria nel parco. La sequenza onirica finisce dentro a un taxi e poi verso un ospedale, con i soldi nel taschino della camicia, mentre un’ambulanza, ironicamente, va a recuperare qualcun altro. La canzone continua con il suo andamento languido e il piano di Mick Ronson fino a quando Renton arriva a destinazione, viene trasportato su una barella e rianimato da un'infermiera. "Raccoglierai solo ciò che semini", canta Lou Reed mentre Renton riemerge dalla moquette del pavimento e ansima bramoso per un po’ d’aria. Mai come in questo caso, c’è una chiara contravvenzione a uno dei principi delle colonne sonore della Hollywood degli anni Cinquanta e Sessanta: la “non udibilità” della musica per lasciare lo spettatore concentrato sulla pellicola.
Gli esempi di grande utilizzo di canzoni note in film d’autore continuano per tutto il decennio e si moltiplicheranno negli anni Duemila. Sul finire del secolo, due in particolare meritano di essere ricordati, entrambi usciti nelle sale nel 1999. Nel primo, Paul Thomas Anderson ci racconta l’epopea di un gruppo di persone in cerca di amore e redenzione nella San Fernando Valley. Tra piogge di rane e coincidenze improbabili, le vite si intersecano e a un certo punto i personaggi si mettono a cantare nella scena più memorabile del film. Cantano quello che sentono in una sequenza che unisce corpo e anima e che invece di risultare ridicola, è toccante e commovente. Anche perchè la canzone è “Wise Up” di Aimee Mann e il film è “Magnolia”. Il secondo film è tratto invece dal primo romanzo di Chuck Palahniuk che vende i diritti cinematografici per soli 10.000 dollari, dopo averne raccolto solo 6.000 con la sua pubblicazione. Il romanzo e il film parlano di consumismo americano, marketing e corporativizzazione, e di come queste cose ci spogliano della nostra individualità. Alienazione, insonnia, schizofrenia e la bassissima percentuale di grasso nel corpo di Brad Pitt. Quando “Fight Club” esce, è un fiasco. L’anno dopo arriva l’edizione in DVD e inizia un riscatto che lo porterà a vendere oltre sei milioni di copie. Tutti quelli che lo hanno visto si ricordano la scena finale. Il progetto Mayhem arriva a compimento e la canzone di un gruppo americano, frutto di un’esperienza subacquea ai Caraibi del leader Black Francis, accompagna la fine degli anni Novanta e del consumismo, o, come si direbbe oggi, semplicemente un reboot. “Where Is My Mind?”.
Appuntamento a presto per la terza parte del ra cconto su “At The Movies: Le Canzoni al Cinema”. Nel frattempo, qui la playlist che accompagna il viaggio e qui la prima parte.
