Il talento e la foga galante di Domenico Modugno
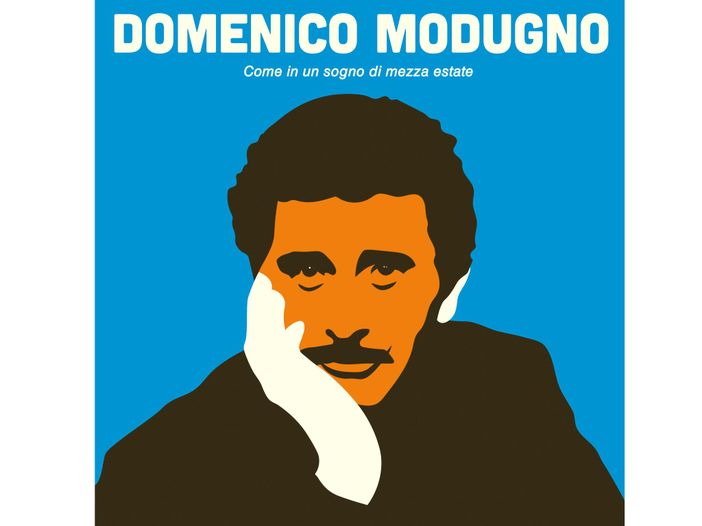
Ma quale monumento della canzone italiana. Domenico Modugno è stato l’acrobata, il pioniere dell’aria, l’imprendibile razzo, radicato nella terra e proiettato verso l’alto, fino a diventare asteroide 6598. Era insieme memoria e visione, corpo teatrale e suono: onomatopeico, di una sveglietta, di un arpionamento, o melodico, drammatico, ironico. Era talento e foga galante, un apripista che si staccò dai legacci del provincialismo per mostrare altri spazi mentali. Non a caso s’intitola “Come in un sogno di mezza estate” la raccolta che lo vuole far scoprire alle nuove generazioni (non fossero bastati i tributi di Negramaro e Ermal Meta), in ogni formato: digitale, doppio Lp, doppio Cd (con versioni in spagnolo dei brani più celebri mai pubblicate in Italia). I sogni Mimmo li faceva ad occhi aperti, quando lavorava come pesatore d’uva, cameriere, facchino, gommista, quando chiedeva un letto e una razione al convento dei frati camaldolesi, e bussava alle porte di Cinecittà, in attesa di diventare ciò che era: un attore, cantante, autore, musicista, di straordinaria carica comunicativa. Tanta fame e tanta fama. All’estero credono ancora che “Volare” sia l’inno nazionale italiano. Questo 2024 è pieno di anniversari brutti che lo riguardano (quarant’anni dal suo ictus, trenta dalla sua morte). Gli anniversari belli li ripercorriamo con suo figlio Massimo.
Settant’anni fa, l’esordio discografico di Modugno. Sono del 1954 brani come “Lu pisce spada” e “Lu minaturi”. Sdoganò quello che oggi chiamiamo folk?
«Erano canzoni in brindisino stretto che alcuni scambiarono per siciliano. Lui cercava un linguaggio nuovo, diverso, più vitale rispetto a quello che si sentiva in giro, e, sì, all’epoca non era così ovvio portare il dialetto su scala nazionale. Riconobbe questa nobiltà ai dialetti e il suo nome cominciò a circolare prima fra gli intellettuali».
S’ispirava alle voci del popolo, a quel modo arabeggiante di richiamare da sotto le finestre.
«Da piccolo si era innamorato di quel tipo di canto, ascoltando i venditori di sale, i pescatori, e soprattutto i carrettieri all’alba. Era fissato con i carretti, li collezionava. Lasciò la Puglia per cercare fortuna a Torino, a Roma, ma si portò le radici nel bagaglio».
Concorda con chi lo definisce il primo cantautore italiano?
«Certo. Innanzitutto nel 1958 era strano che un autore interpretasse un proprio brano. Fu quasi obbligato a farlo, perché “Nel blu dipinto di blu” venne proposta a tutti i cantanti e da tutti rifiutata. Poi lui non era un cantante tradizionale, non puntava ai gorgheggi e agli acuti. Fu dirompente. In più, al tempo i testi parlavano di mamme e di fiori, invece lui e Franco Migliacci azzardarono l’immagine di un volo, con tanto di braccia spalancate, non la solita postura ingessata. Fu un’esibizione preparata a lungo»
Sapeva che era un gesto importante?
«Lui era consapevole di tutto, dalla composizione all’esposizione. In quel caso, incarnava la fiducia nell’Italia che ripartiva dopo la seconda guerra mondiale».
Finalmente si tornava a guardare il blu del cielo, senza paura delle bombe.
«E infatti blu fu il disco, il primo vinile colorato della storia. Tra l’altro l’Italia non si era qualificata ai mondiali di calcio, lui la riscattò portandola in cima al mondo».
Sessantacinque anni fa, la vittoria di due Grammy, come miglior registrazione dell’anno e canzone dell’anno. Frank Sinatra era il favorito. Vero che erano rivali?
«No, per due motivi. Il primo è che per i veri artisti la competizione è con sé stessi, non con gli altri. Il secondo è che già anni prima Sinatra aveva ascoltato Modugno cantare una ninna nanna siciliana e ne era rimasto colpito. Quando se lo ritrovò ai Grammy, fu felice che a vincere fosse lui, un italiano»
Un italiano che peraltro cantava in italiano, non in inglese.
«Esatto, ancora più prezioso. Papà voleva assolutamente avere successo nella sua lingua, così varia e musicale. Arrivava ovunque anche se a molti era sconosciuta. Quando ho letto “Filosofia della canzone moderna” di Bob Dylan, mi sono commosso. Ha dedicato tante pagine a Modugno, proprio raccontando del sentimento che gli provocava pur non capendo una parola, e di quanto suonasse bene l’italiano (“con le sue vocali come caramelle mou e il melodioso vocabolario polisillabico” ndr). Dylan, in quegli anni, visse appieno il delirio americano di “Volare”».
L’America impazzì. La Decca certificò che quel brano mise fine alla recessione nelle vendite dei dischi.
«Vendette talmente tanto che l’etichetta non faceva in tempo a ristamparlo. Sessantamila copie al giorno: lo stamparono anche senza copertina. Fu primo su “Billboard” per molte settimane, ospite al “Carson Tonight Show”, che era come i moderni “David Letterman Show” o “Saturday Night Live”. Papà mi raccontava che capì la portata del suo successo quando vide un nativo americano che infilava a ripetizione i gettoni nel juke-box per sentire “Volare”».
Negli Stati Uniti incontrò anche Elvis.
«In quel momento Modugno era un Dio, e Elvis lo trattò alla pari. Qualche anno dopo Presley gli telefonò per chiedere di poter cambiare le parole al brano “Io”, che nel 1964 diventò “Ask me”».
Sempre nel 1959 vinse di nuovo il Festival di Sanremo, con “Piove (Ciao ciao bambina)”, che andò all’Eurovision. È uno dei brani tradotti in spagnolo.
«”Piove” in Venezuela non era ancora arrivata eppure le radio già la passavano e all’aeroporto trovò una folla di ammiratori. Il Sudamerica lo adorava. “Dios, como te amo” (“Dio, come ti amo”, che vinse il Sanremo ’66 ndr) rimase sedici anni in classifica».
Altro anniversario: 50 anni fa Modugno vinceva la prima edizione del Premio Tenco. Luigi Tenco amava le canzoni di suo padre. Si conoscevano?
«Non mi sembra. So che papà e Riccardo Pazzaglia scrissero “Meraviglioso” e la presentarono a Sanremo l’anno dopo il suicidio di Tenco. Fu scartata. Era un inno alla vita ma menzionava un uomo che intendeva togliersi la vita, quindi la commissione la ritenne inopportuna. Avrebbe tranquillamente vinto».
Non furono poche le censure. Penso a “Un calcio alla città”, letto come un invito all’assenteismo, “Lazzarella” e “Vecchio frack”, che infastidirono i moralisti.
«E ancora scandali per “Libero”, “Resta cu ‘mme”. Era sempre trasgressivo. Non credo che soffrisse molto le censure. Si limitava a cambiare qualche verso e poco dopo le cantava come voleva lui».
“Vecchio frack” è la canzone d’autore per eccellenza. Si racconta che la compose di notte, al Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio, seduto sui sedili strappati alla sua vecchia macchina.
«E di lì passò Anna Magnani, che lo ascoltò e disse a mia madre: «Tienitelo stretto che questo avrà successo!».
Nel 1964 – altra ricorrenza - vinse il Festival di Napoli con “Tu si' 'na cosa grande”, tra le più belle canzoni napoletane. Scritta da un pugliese.
«Forse la mia preferita. Una canzone stupenda, priva di ritornello, e ancora suonatissima dai jazzisti. Fece suo anche il dialetto napoletano, ma inseguendo ancora una volta il suono. Invece di “gruosso”, preferì dire “grande”. Con Pazzaglia poi scrisse “‘O ccafè”, che ispirò la “Don Raffaè” di Fabrizio De André».
Nel 1970 andò da Arbore a “Speciale per voi”, un’arena di giovani che contestarono quasi tutti, compreso Lucio Battisti. Modugno, non più giovanissimo, fu applaudito. Qualcuno gridò «Sei come Jimi Hendrix!». Se lo spiega?
«Credo percepissero la sua autenticità. Gli riconoscevano di aver aperto una strada, e poi si capiva che era uno controcorrente. Era stato uno dei primi a portare i capelli lunghi, si diceva figlio di un principe zingaro, ha sempre rotto gli schemi, fatto a modo suo, senza farsi influenzare. Difficile attaccare un simile mostro di bravura e genialità. Una personalità indomita».
Duettaste in “Delfini”, fu la sua ultima incisione. Cosa le insegnò?
«La prima cosa che mi disse fu: «Massimo, quando canti, pensa sempre alle parole». Nasceva come attore, dava peso e quindi senso a ogni parola».
Forse anche per questo i letterati lo stimavano? A John Cheever ispirò il racconto “Mariti in città”; Pasolini, e un Quasimodo fresco di Nobel, vollero collaborare con lui.
«Pasolini frequentava la nostra casa, diventò un amico di famiglia, e insieme fecero una perla intitolata “Che cosa sono le nuvole?”. Quasimodo accettò di far musicare le sue liriche solo da Domenico Modugno. Queste attenzioni dei “colti” lo lusingavano ma ci teneva a restare umile. Era profondamente legato alle sue origini modestissime. L’umiltà, per lui, è la virtù dei grandi e l’arte è la massima espressione dell’uomo. L’arte è il contrario della guerra».
