"Lateral" - At The Movies: Le Canzoni al Cinema
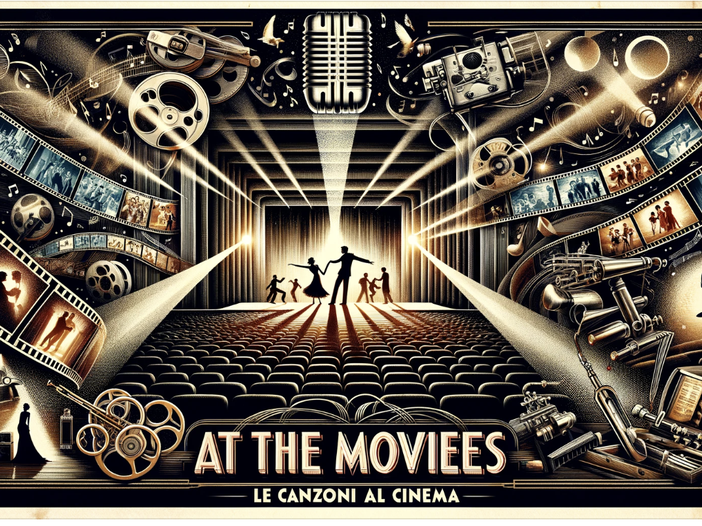
Lateral è un appuntamento periodico di Rockol per attraversare la storia della musica popolare, alta e bassa, e offrirne una vista, appunto, laterale.
§§§
Alcune delle più grandi scene della storia del cinema sono memorabili proprio perché accompagnate dalla canzone perfetta. Una relazione simbiotica tra adattamenti di musical, canzoni originali, pezzi editi famosi o da riscoprire che nasce negli anni Sessanta, matura nei Settanta e negli Ottanta, per poi esplodere definitivamente negli anni Novanta con l’approccio compilativo di Tarantino e Scorsese prima, e di Wes Anderson e Sofia Coppola poi. Da “Il Laureato” a “Quei Bravi Ragazzi”, da “Saturday Night Fever” a “Trainspotting”, da “Pulp Fiction” a “Caro Diario”, tra trailerisation ed effetto jukebox, un viaggio in tre puntate tra le canzoni e i film più belli della storia, insieme.

Terza Parte
Con l'inizio del nuovo millennio sembra che tutti i registi, indipendenti e non, realizzino film mescolando canzoni vecchie e nuove, note e di nicchia così spesso da renderlo un approccio mainstream. Siamo entrati con tutti e due i piedi nell’era della retromania ed è chiaro per tutti che questo tipo di colonne sonore sanno premere efficacemente sul pulsante della nostalgia, per creare connessioni emotive tra scene e personaggi di un film e le memorie dello spettatore.
In questo contesto, si afferma una nuova generazione di filmmaker che contribuisce a ridefinire il rapporto tra pellicola e canzoni. La prima di loro è Sofia Coppola, una maestra nel mischiare piani temporali usando musica contemporanea per accompagnare storie ambientate nel passato. Il suo primo lungometraggio, “The Virgin Suicides” del 1999 (tratto dall’omonimo libro di Jeffrey Eugenides uscito sei anni prima e tradotto in italiano come “Il giardino delle vergini suicide”) è ambientato nei sobborghi del Michigan anni '70 e vede accanto alla colonna sonora composta in gran parte dagli Air, canzoni degli alt-rocker Sloan fianco a fianco con Todd Rundgren. Coppola scopre per caso la musica degli Air, imbattendosi nel loro EP di debutto “Premiere Symptoms” in un negozio di dischi mentre sta lavorando alla sceneggiatura. Il retro-romanticismo della band, ricco di Moog e altri sintetizzatori analogici, disegna la cifra del film e diventa un'ispirazione importante nel processo di scrittura. Quando arriva il momento di trovare un compositore per la colonna sonora, è naturale per la Coppola cercare di collaborare con il gruppo francese. La musica trova un abbinamento perfetto con la fotografia nostalgica del film che racconta gli ultimi giorni delle sorelle Lisbon, mentre vengono corteggiate da un gruppo di ragazzi del quartiere. Nello scrivere la colonna sonora, Godin e Dunckel attingono a piene mani dalle loro esperienze di adolescenti infelici e riescono a creare una canzone praticamente perfetta con “Playground Love”, la cui melodia fa da sottofondo alla scena notturna al campo da football e al risveglio di Lux (Kristen Dunst), sedotta e abbandonata da Trip (Josh Hartnett), il bello della scuola. “I’m a high school lover and you’re my favorite flavor”. A gettare un ponte immaginario tra ambientazione della storia e data di uscita del film, ci pensa "Ce matin-là", sempre degli Air, recuperata dal loro secondo album che tra archi e tuba sembra scritta da Bacharach ed è il complemento ideale della scena dai contorni traslucidi che ci presenta le sorelle al completo.
Passano quattro anni e Sofia Coppola ci racconta di Bob (Bill Murray) un attore di mezz’età a Tokyo per girare la pubblicità di un whisky giapponese, con l'intesa che lo spot non sarà mai mostrato negli Stati Uniti. A fargli compagnia c’è una giovane ragazza, Charlotte (Scarlett Johansson), neolaureata in filosofia, al seguito del marito fotografo in un viaggio di lavoro. Turbata dai grandi grattacieli della capitale giapponese, passa la gran parte del tempo a interrogarsi sulla sua vita e sul suo futuro. Due personaggi ugualmente soli, confusi e alienati che si ritrovano insieme, divertendosi e confidandosi le paure più personali, in un’intimità che va oltre il desiderio. Nasce un legame teneramente profondo - un po’ amicizia, un po’ storia d’amore - che si sublima in un veloce bacio d’addio accompagnato da una frase che lui sussurra all’orecchio di lei. Una frase che nella sceneggiatura di “Lost in translation” non c’è e che forse proprio per questa ragione scatena una serie infinita di teorie e congetture che accompagnano il film dalla sua uscita ad oggi. Mentre Bob si allontana riluttante dall'abbraccio di Charlotte, camminando all’indietro e guardandola sorridere tra le lacrime, nell’aria rimane qualcosa di irrisolto. Parte una rullata di batteria e, in perfetta sincronia con l'apparire di un ampio sorriso sul volto di Bil Murray, arrivano i primi accordi di chitarra di "Just Like Honey" dei Jesus and Mary Chain. Tutto quello che Bob e Charlotte hanno vissuto nei pochi giorni insieme sembra trovare una sintesi: l’imprevista felicità di sentirsi vicini, anche se per poco, il lasciarsi e conservare il ricordo piacevole e irripetibile di quell’incontro. Tutto in una canzone che accompagna il viaggio di Bill Murray in aeroporto. “Listen to the girl, as she takes on half the world”, cantano i fratelli Reid.
Più o meno contemporaneamente alla Coppola, si affaccia sulle scene la versione Caran D’Ache di Tarantino, Wes Anderson. Collocandosi in una terra di confine tra il twee e il nerd, Anderson propone uno stile visivo immediatamente riconoscibile, eccentrico e poetico al contempo, raccontando storie di dolore e di famiglie disfunzionali, definite dalla perfetta simmetria delle immagini. Come Tarantino, ha un approccio indie alla musica, la tendenza a cercare gemme nascoste e dimenticate – soprattutto dai ’60 e dai ’70 -, a riciclare colonne sonore di film del passato e una grande capacità di sincronizzazione tra momenti della canzone e lo sviluppo della scena e dei dettagli al suo interno. Diversamente da Tarantino, le canzoni non sono commenti ironici, ma servono più a descrivere gli stati emotivi dei personaggi o a catturare un’atmosfera e un periodo storico specifico. Il tutto si traduce in un pastiche raffinato di cultura pop, disseminato di needle drop, più implosivi che esplosivi, ma di rara efficacia.
La scena in slow motion che vede Margot (Gwyneth Paltrow) scendere da un autobus verde pastello e dirigersi verso Richie (Luke Wilson) ne “The Royal Tenenbaums” è una dimostrazione esemplare. C’è prima un breve silenzio che consente ai due di agganciare gli sguardi e poi partono le note di "These Days" di Nico, a rappresentare in un modo intimamente romantico la loro relazione, complicata sin dal principio (i due sono fratelli adottivi). Dopo qualche accordo di chitarra acustica, entrano gli archi e la canzone recita "Non parlo troppo in questi giorni", quasi come se Richie e Margot potessero leggere l'uno nella mente dell'altro mentre si avvicinano. Tutto intorno la palette è limitata a pochi colori che sembrano costringerti all’interno della scena. Sono solo cinquanta secondi, ma c’è tutto quello che serve, con una potenza sottile che toglie il fiato. Si dice che Jackson Browne si sia sentito così trasportato guardando la sequenza da pensare, non senza una nota di malinconia: "Questo ragazzo suona come suonavo io". Senza capire, almeno nell’immediato, che quel ragazzo è lui, solo 30 anni prima. Dopo il film, Browne torna a suonare la canzone nei suoi concerti esattamente come in questa versione. Margot e Richie tornano protagonisti in un’altra sequenza del film. Da una scena in esterni, i due passano all’interno di una tenda, finalmente soli, in compagnia di un giradischi. La musica diventa quindi diegetica quando lei mette sul piatto il vinile di “Between The Buttons” dei Rolling Stones. Wes Anderson lascia che l'album si inserisca nella lunga scena di amore non corrisposto tra i due che a un certo punto si baciano. Pochi secondi e lei chiede "You're not gonna do it again, are you?". Lui risponde "I doubt it" e parte “Ruby Tuesday”, con un’accelerazione emotiva quasi insostenibile, devastante e casuale allo stesso tempo. Mentre lei si alza e bacia la mano di lui, piangendo, la prima frase della canzone recita “She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone”.
Anderson continuerà a disseminare di canzoni i suoi film. Tra i tanti ricordiamo l’uso di “Life On Mars?” di “David Bowie” in “The Life Aquatic With Steven Zissou”. In pochi secondi, Bill Murray, l'eccentrico oceanografo protagonista del film, annuncia i suoi propositi di vendetta nei confronti dello squalo giaguaro che si è mangiato il suo partner Esteban e prende consapevolezza di essere padre. A questo punto, il piano di Rick Wakeman che si intuiva sotto il dialogo e i rumori ambientali della festa, lascia il posto alla voce di David Bowie che arriva improvvisamente in primo piano con il chorus della canzone che accompagna Zissou mentre attraversa il pontile e arriva sulla prua, dove si accende una sigaretta.
Difficile trovare altri registi all’altezza di Sofia Coppola e Wes Anderson in questo squarcio di secolo nell’arte di unire immagini e canzoni. Sono loro gli indiscussi eredi della tradizione di Scorsese e Tarantino. Più facile trovare altri esempi, magari interessanti, ma di minor spessore artistico. Uno di questi è Cameron Crowe che inizia la sua carriera da enfant prodige come redattore nel periodo di massimo splendore della rivista musicale americana “Rolling Stone”, gli anni '70. Quasi naturale attendersi da lui una predisposizione all’arte della sincronizzazione, soprattutto in periodi recenti dove il sentimento militante contro l'utilizzo - che fa tanto establishment - del rock negli spot e nel cinema è venuto meno. Fin dal debutto, Crowe fa ampio uso di canzoni note e recenti nei suoi film, tra i quali “Singles”, celebrazione della grunge generation di Seattle, dove ascoltiamo tra le altre “Wound” degli Alice In Chains. Si sposta velocemente verso un approccio più a catalogo, a base di grandi classici, già nella pellicola successiva, “Jerry McGuire”, dove Tom Cruise canta a squarciagola “Free Falling” di Tom Petty e continua in “Vanilla SKY”, dove "Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space", degli Spiritualized accompagna la scena in cui il David Aames di Tom Cruise - corpo criogenicamente congelato, ma cervello attivo sospeso in un labirintico sogno lucido - sale in ascensore fino alla cima di un grattacielo color perla. Esce sul tetto e rimane sbalordito sotto un cielo surreale e impressionista, come un dipinto di Monet, mentre è alla continua ricerca di nuove fonti di dopamina. "Tutto quello che voglio nella vita è un po' d'amore per portare via il dolore", canta Jason Pierce, su una melodia presa in prestito da "Can't Help Falling in Love" di Elvis Presley.
Tra “Jerry McGuire” e “Vanilla Sky”, Cameron Crowe porta nelle sale il suo film migliore, il semi autobiografico “Almost Famous” che vede un giovane ragazzo, Patrick Fugit, scrivere articoli per una rivista musicale e seguire per gli Stati Uniti, con crew e groupies, il girovagare di una band troppo simile a tante altre per farcela davvero, gli Stillwaters, capitanati dal chitarrista a cui presta il volto Billy Cudrup. Crowe cerca di ottenere i diritti di "Stairway to Heaven", per cui ha già girato una sequenza di sette minuti, ma i Led Zeppelin confermano la loro volontà di non venderla né commercializzarla, decisione poi ribadita nel tempo. Tocca quindi a una canzone di Elton John segnare il momento centrale del film e diventare uno dei più celebri singalong cinematografici di tutti i tempi. Al culmine di una progressiva crisi della band, il chitarrista degli Stillwaters litiga con gli altri membri, se ne va con il giovane Patrick a una festa post concerto a Topeka, consuma una grande quantità di birra corretta con LSD e salta in piscina dal tetto di una casa, proclamandosi golden god. Le note di “Tiny Dancer” segnano il momento in cui Billy Crudup si riunisce timidamente agli altri membri degli Stillwater sul tour bus. Nessuno parla e la tensione è palpabile. La band è arrivata al capolinea. All’inizio sembra che il regista faccia un uso non diegetico della canzone - la sentiamo come spettatori, ma non la sentono i personaggi sul set -, anche perché le note di Elton John commentano la sequenza delle persone che salutano e accompagnano le riprese del pullman sulla strada. Il volume della canzone non varia quanto la scena si sposta all’interno del tour bus ed è solo quarantacinque secondi dopo - il batterista della band sembra accompagnare il drumming della canzone - che si ha il primo dubbio che la canzone sia invece utilizzata diegeticamente. Poco più di dieci secondi e le incertezze sono spazzate via, quando il bassista inizia a cantarla e ad uno ad uno i membri degli Stillwater, le groupies e tutta la crew si uniscono, mentre ricompaiono sorrisi e cenni di intesa, fino al chorus liberatorio al quale si aggiunge anche Billy Crudup. Nonostante tensioni e incomprensioni, la band è ancora unita. Anche il giovane Patrick si arrende e inizia a cantare prima di dire alla groupie Penny Lane (Kate Hudson) che deve tornare a casa, solo per sentirsi rispondere "Sei a casa". Due giorni per girare una scena che dura poco più di due minuti e rendere alla perfezione il potere delle grandi canzoni di sanare spaccature e litigi, in un film che riesce ad essere contemporaneamente una storia agrodolce di formazione, un'evocazione della cultura rock metà anni '70 e una lettera d'amore alla musica. “Tiny Dancer” nell’anno di uscita del film non è certamente tra le canzoni più famose di Elton John. Grazie ad “Almost Famous”, un film che in qualche modo la ridefinisce, sembra che improvvisamente tutti la conoscano.
La trasversalità dell'uso di canzoni di repertorio non risparmia i film di super eroi. Tra tutti, c’è un franchise che prende la lezione della colonna sonora compilativa, ne fa una versione da discount e ci regala un trittico che saccheggia a piene mani i Settanta e i primi Ottanta, soprattutto americani. Il regista è James Gunn, i film sono “Guardians Of The Galaxy Vol. 1, 2 e 3”. Il giochino parte bene: il protagonista da bambino ha ricevuto in dono dalla madre prima di morire un walkman e una cassetta, l’Awesome Mix, e ce l'ha con sé quando è rapito dagli alieni. La musica diventa quindi la connessione emotiva con la madre (sia quella biologica, sia la Terra) quando si ritrova nelle vesti di avventuriero spaziale. Tutto quello che lo riporta a un’infanzia felice, alle sue radici, ai suoi affetti è in quella cassetta. James Gunn segue il metodo Quentin ricercando e compilando playlist mentre scrive il primo capitolo della trilogia. Alcune volte va alla ricerca di una canzone dal suo mix per adattarla a una scena, altre volte sono le stesse canzoni che lo ispirano. Nella maggior parte dei casi, Gunn sceglie brani popolari, ma non così conosciuti oggi, riscoprendo artisti e band un po’ dimenticate, secondo il concetto di “semi-familiarità” che tanto successo sta avendo nel cinema degli ultimi trent’anni. Con approccio analitico passa in rassegna tutte le classifiche americane degli anni ’70, seleziona qualche centinaio di canzoni che poi screma alla ricerca di un set che abbia la giusta aderenza al film. Tra i pezzi più famosi, “Mr. Blue Sky” della “Electric Light Orchestra”, a supporto dei titoli di testa del Vol. 2 della serie, e “The Chain” dei Fleetwood Mac. Il gioco funziona bene nel primo capitolo e in parte del secondo, per poi implodere in un inutile gigantismo che fa l’exploitation dell’idea di partenza e annoia. Interessante notare come nella messe dei brani utilizzati figuri quella che è tra le canzoni “semi-familiari” più sfruttate dal recente cinema americano e non. “Boogie Nights” e “Summer Of Sam” sono solo due dei tanti film che hanno utilizzato “Fooled Around And Fell In Love” di Elvin Bishop, l’epitome di quel suono americano che frequentava le classifiche di metà Settanta, tra adult oriented rock e blues. La classica canzone che quasi tutti riconoscono e pochissimi ricordano chi la canta (peraltro Elvin Bishop decide di lasciare il vocal della sua unica Top Ten a Mickey Thomas, futuro Jefferson Airplane) e che ci dà l’opportunità di sconfinare nell’horror per parlare di quello che figura tra i film più riusciti della prima decade del secolo. Un western-horror, a vedere bene, dove il regista Rob Zombie prende i personaggi del precedente “House Of 1000 Corps” e li spedisce in un viaggio on the road, tra atmosfere di Terrence Malick e Sam Peckimpah. Diversamente da tanti horror moderni, in “The Devil’s Rejects” non ci sono canzoni heavy metal, ma Zombie attinge a piene mani a brani dell'epoca dell'ambientazione cinematografica, con particolare riferimento a certo southern rock e al folk visionario di Terry Reid, oltre naturalmente a “Fooled Around and Fell In Love”. Le canzoni sono scelte in modo che i testi promuovano associazioni emotive con i personaggi, restituendo, almeno parzialmente, un tocco di umanità ad assassini che si divertono ad uccidere. In una bellissima colonna sonora, ci sono almeno tre brani che meritano di essere ricordati. “Midnight Rambler” della Almann Brothers Band accompagna i titoli di testa che arrivano a dieci minuti dall’inizio del film, con i fratellastri Otis Driftwood e Baby Firefly che scappano dalla loro casa dopo un attacco su larga scala della polizia. Tra fermi immagine, fotografia sgranata e colori desaturati, la voce di Gregg Allman che canta “But I'm not gonna let 'em catch me” è semplicemente perfetta. Come in altri momenti, anche se l’azione continua – i due ne approfittano per ammazzare una malcapitata e rubarle l’auto – la canzone è l’unico suono che si sente, sostituendosi completamente ai dialoghi e ai rumori di scena e in qualche modo inserendo una componente di sospensione della realtà nella visione. Stessa modalità con la scena successiva che vede lo sceriffo Wydell catturare e apprestarsi a torturare i due fratelli e il padre di Baby, Capitan Spalding, in una sequenza che sembra ribaltare ruoli di buoni e cattivi. È la volta di “To Be Treated Right” cantata dalla splendida voce di Terry Reid – l’uomo che ha declinato l’opportunità di diventare il cantante di Led Zeppelin e Deep Purple – a fungere da commento sonoro, tra ralenty e primi piani. “Oh, we are what we are when in danger”. Pochi minuti e si arriva alla scena finale del film. Otis, Baby e Captain Spaulding sono in qualche modo sopravvisuti alle torture e, più morti che vivi, fuggono in auto. La macchina da presa li segue dall’alto sulle strade deserte della California orientale quando entrano l’organo e l'iconica chitarra slide di “Free Bird” dei Lynyrd Skynyrd. Si alternano scene dal passato che li descrivono come una famiglia normale e immagini del presente, insanguinati e in fin di vita in auto, dando allo spettatore il modo di dimenticarsi per qualche momento dei morti che hanno lasciato alle spalle e relazionarsi a questa famiglia sadica e ultra disfunzionale. Quando sembra che ce l’abbiano fatta, c’è un ultimo colpo di scena: un blocco della polizia. I tre si fermano, si guardano e pistole in mano vanno contro il plotone di esecuzione proprio mentre “Free Bird” accelera ed entra l’assolo di Allen Collins. Non si arrenderanno senza combattere. Preferiscono morire piuttosto che essere catturati. Nell’ennesimo slow-motion dell'auto che si avvicina, i proiettili colpiscono i loro corpi, ma continuano ad andare avanti, fino a quando lo schermo diventa nero. Silenzio. Poi colpi di pistola. “And this bird you cannot change”.
Appuntamento a presto per la quarta parte (bonus) del racconto su “At The Movies: Le Canzoni al Cinema”.
Nel frattempo, qui la playlist che accompagna il viaggio, qui la prima parte e qui la seconda parte.
