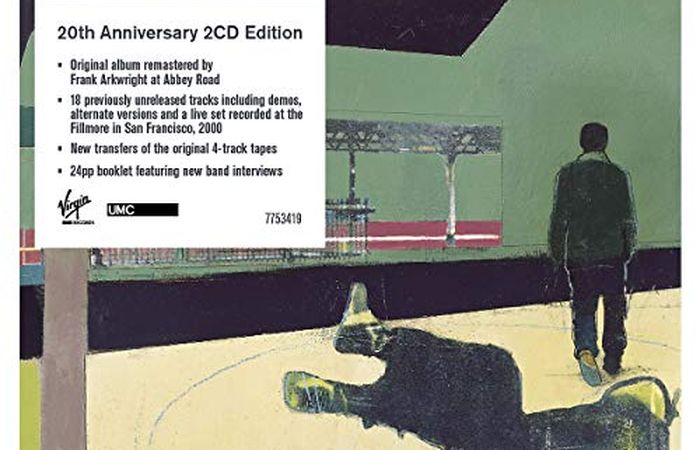 Quando hanno esordito con “Bring it on”, sono stati subito accolti come
il gruppo che poteva dare la giusta iniezione di idee nuove al rock inglese.
I Gomez sono sembrati subito come una sintesi di conoscenza del passato e
attenzione per ritmi e suoni contemporanei. Adesso il ruolo di “grande
rivelazione” è passato ad altri e i Gomez tirano dritti per la loro strada:
il nuovo album “In our gun” segna un passo avanti dal punto di vista della
cura delle sonorità, mantenendo la caratteristica densità delle canzoni.
Come accadeva anche nei dischi precedenti, in un solo pezzo dei Gomez
sembrano trovare posto idee che altri musicisti avrebbero sviluppato lungo
tre o quattro brani. E’ una caratteristica che fatalmente allontana il
gruppo dalla possibilità di azzeccare il classico singolo
“sfondaclassifiche”, ma è anche una dote fondamentale che distingue Gomez da
molti altri gruppi in circolazione; E comunque a loro va benissimo così,
come ci ha spiegato il cantante, chitarrista e tastierista Tom Gray.
Quando hanno esordito con “Bring it on”, sono stati subito accolti come
il gruppo che poteva dare la giusta iniezione di idee nuove al rock inglese.
I Gomez sono sembrati subito come una sintesi di conoscenza del passato e
attenzione per ritmi e suoni contemporanei. Adesso il ruolo di “grande
rivelazione” è passato ad altri e i Gomez tirano dritti per la loro strada:
il nuovo album “In our gun” segna un passo avanti dal punto di vista della
cura delle sonorità, mantenendo la caratteristica densità delle canzoni.
Come accadeva anche nei dischi precedenti, in un solo pezzo dei Gomez
sembrano trovare posto idee che altri musicisti avrebbero sviluppato lungo
tre o quattro brani. E’ una caratteristica che fatalmente allontana il
gruppo dalla possibilità di azzeccare il classico singolo
“sfondaclassifiche”, ma è anche una dote fondamentale che distingue Gomez da
molti altri gruppi in circolazione; E comunque a loro va benissimo così,
come ci ha spiegato il cantante, chitarrista e tastierista Tom Gray.
Nei Gomez siete in tre a cantare e le canzoni sembrano nascere da spunti diversi. Come lavorate ai vostri pezzi?
Abbiamo tutti attrezzature separate. Io registro qualcosa e qualcun’altro lo prende ci aggiunge le sue cose. Poi colleghiamo le macchine e mettiamo insieme tutto. E’ molto rapido e spontaneo, proviamo delle idee e se non funzionano le abbandoniamo. Non sentiamo alcuna pressione, forse ogni tanto c’è qualche problema per il fatto che ognuno tende a distorcere l’idea dell’altro, a farla propria.
E’ difficile trovare un equilibrio in questa situazione?
Ce lo chiedono sempre, ma in realtà non è affatto difficile per noi, lo facciamo e basta. Solo raramente incappiamo in qualcosa che ci blocca, di solito tutto sembra funzionare. Non so perché. Siamo uno dei pochi gruppi che lavora davvero come un collettivo più che come un insieme di individui, ma non sappiamo veramente in che modo funzioniamo. Tutto quello che so è che più o meno ogni settimana abbiamo una canzone finita.
Le vostre canzoni possono anche confondere all’ascolto, sono piene di suoni e non sembrano mai seguire una sola direzione...
La mia idea di disco perfetto è quello dove a metà ti rendi conto di non ricordarti come è iniziato e devi tornare all’inizio per scoprirlo e cercare di seguire. Mi piace tutto questo. Molti gruppi oggi pensano di dover avere un suono particolare e mantenerlo per tutto un album. Spesso hanno una o due canzoni buone e altre otto che suonano in modo simile. Io non vedo alcun motivo per agire così quando hai a disposizione molti suoni e puoi decidere di farne quello che vuoi. Non vedo perché si debba decidere di mantenersi all’interno di un solo stile e non aprirsi a suoni e generi diversi: è questo che fa progredire la musica. E non è una questione di abilità tecnica, è legato a tutto quello che rende buona la musica, il vibe, il feel, ma ne fa qualcosa di più complesso e profondo.
Comunque anche a voi capita di scrivere pezzi piuttosto lineari: sull’ultimo album c’è “Ballad of nice and easy”, ad esempio.
E’ un modo ottimista per chiudere l’album. Penso che tutto l’album sia fondamentalmente ottimista, anche se alterna luci e ombre. E’ stato registrato dopo un momento di pausa e penso che si senta il fatto che abbiamo recuperato energie dopo aver trascorso tre anni sulla strada.
Visto che lo spirito è ottimista, come mai avete scelto un titolo “In our gun”,che evoca semmai un’immagine violenta?
Be’, il titolo viene da una delle canzoni del disco. Penso che sia un riflesso del periodo in cui è stato registrato. Tra primavera e autunno dell’anno scorso stavano accadendo molte cose strane: in Inghilterra c’erano scontri razziali, George Bush è stato eletto e ha cominciato a parlare di missili... C’era qualcosa di evidentemente sbagliato nel mondo, e nessuno sembrava avere il controllo della situazione. La canzone tratta del fatto che ci sentiamo tutti in qualche modo semplici pedine nel gioco, ma non è una canzone politica, esprime più che altro un sentimento di frustrazione, che poi viene liberato nel finale, in una specie di attacco strumentale ad alto volume in stile Motorhead.
A proposito di Motorhead, è noto che alcuni di voi erano appassionati di metal. Anche tu seguivi la scena?
No, Ian era un fan di Slayer e Metallica. Io ascoltavo Stone Roses e Pixies. E poi c’erano sempre Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, Tom Waits. Ovviamente, ascoltavo anche cose che sentivo dai miei amici, come si fa sempre a quell’età. Gli Stone Roses mi piacevano, sembravano un po’ come i Byrds.
Quando è uscito il vostro primo album, siete stati subissati di critiche entusiastiche, premi, copertine. Poi il rumore intorno a voi si è un po’ calmato. Vi ha dato fastidio o vi ha preoccupato il fatto di essere così incensati all’inizio e poi messi un poco da parte?
Non ci siamo mai preoccupati molto di questo. Forse quando abbiamo esordito siamo stati per molti una boccata d’aria fresca, abbiamo sorpreso molte persone e non è facile riuscire a sorprendere. La gente si entusiasma per le sorprese, è accaduto semplicemente questo. Ovviamente, dopo la prima volta non c’è più la sorpresa, ma non c’è stato niente che sia andato per il verso sbagliato e i dischi hanno continuato a vendere. L’unica ragione per cui esistiamo è registrare dischi che riescano ad appassionare il pubblico.
Il fatto di avere sollevato così tanta attenzione vi ha creato qualche difficoltà?
No, in effetti lavoravamo per tutto il tempo e non ci abbiamo badato, anche adesso è così. Il punto è che non siamo diventati mai molto visibili: non ci presentiamo come celebrità, non andiamo a quel tipo di feste, i nostri amici sono persone normali. Non stiamo cercando di giocare con la mitologia del rock ‘n’ roll e restare coinvolti in tutte quelle stronzate. A molti musicisti piace, ma personalmente non mi trovo a mio agio.
In passato qualcuno di voi ha fatto dichiarazioni contro la moda. Qualche anno fa era un atteggiamento molto diffuso, adesso sembra che molti gruppi rock si preoccupino molto di stile. Volete invertire la tendenza?
Il punto è il concetto di cosa è di moda e cosa no, nella musica, nell’arte. Non penso che questo importi. Viviamo in un mondo dove ci sono riviste che dicono di promuovere uno stile di vita, siamo soggetti a un livello di stronzate quasi inconcepibile. In fondo, qual era lo scopo del punk? Dire “liberiamoci da tutto questo”, reagire. Il modo forse era un po’ violento, ma era un mezzo per riaffermare la propria personalità. Per quanto mi riguarda, ho qualche problema ad adattarmi al fatto che le cose debbano essere fatte in un certo modo, che si debbano fare i conti con pubbliche relazioni, marketing e tutte queste schifezze che non c’entrano un cazzo con la musica. E’ triste perché la musica sta andando in una direzione sempre peggiore. Lo si vede in ogni momento: i gruppi vengono ingaggiati in base alla loro possibilità di avere un mercato largo, non per quello che suonano. E’ una strada pericolosa. La mitologia del rock è stata alimentata da musicisti che avevano un comportamento da star, ma prima di tutto erano persone di grande talento. Se ti limiti a interpretare la parte senza offrire nessun contenuto, diventa solo una questione di superficie, di estetica. Diventa impossibile giudicare cosa sia buono o no, nessuno esprime giudizi di qualità. Tutto si riduce a: se appartenete a questa categoria, leggete queste riviste, vi viene venduto questo e a tutti voi piace questo. Nessuno sembra capace di uscire dallo schema, le radio non trasmettono una canzone se non suona esattamente come quella che hanno appena trasmesso. Perché? C’è un buon motivo? No, lo hanno semplicemente deciso. E ora sono diventate vittime del loro conservatorismo, non possono mandare in onda quello che vogliono. Chi lavora nel business ha imparato a fare compromessi e alla fine nessuno sa più da dove ha cominciato e perché. Sono ciechi che vengono guidati da altri ciechi. Per quanto mi riguarda, la questione è molto semplice: amo la musica e mi piace fare dischi. Non c’è bisogno di avere una filosofia complicata a riguardo. Se sei un musicista e hai un contratto con un’etichetta, tutto quello che devi fare è cercare di registrare grandi dischi.
(Paolo Giovanazzi)