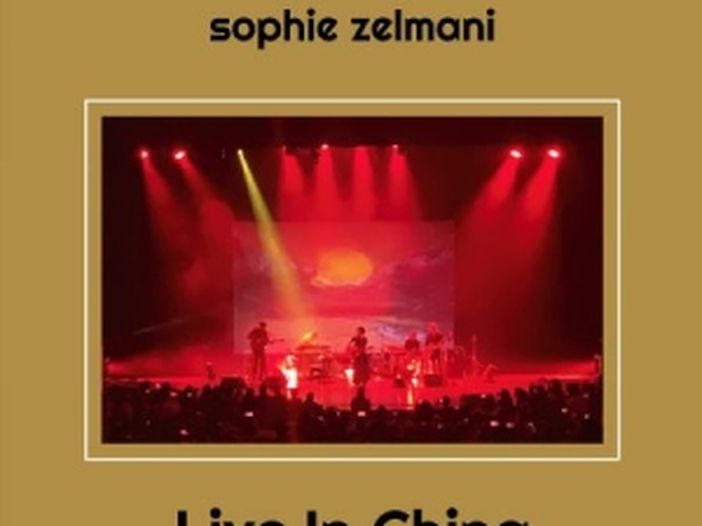
La prima cosa che colpisce di lei è il suo parlare sottovoce, una forma di timidezza e insieme una dimostrazione di leggera insofferenza per i rituali della promozione, il cui risultato è quello di obbligare chi ascolta a un difficile esercizio di intuizione delle sue parole. Sophie Zelmani, che nonostante il cognome vagamente italiano e il sound da cantautrice americana arriva dalla Svezia, non ama parlare di sé e delle sue canzoni; o meglio, non ama ricamarci sopra, spiegare significati che non ci sono. Per lei c’è solo la musica, che descrive con le parole un attimo, una sensazione, nulla di più. “Le mie canzoni parlano di stati d’animo, di situazioni che a volte capitano a me, altre volte vedono coinvolte le persone a me vicine. Le racconto senza stare troppo a pensare a cosa sto esprimendo e perché. Anche il fatto di scrivere in inglese è qualcosa che non ho scelto di fare. E’ venuto così”. Sophie, come si comprende ascoltando il suo terzo album, “Time to kill”, è una persona che ama l’essenzialità: le sue liriche sono ridotte all’osso eppure riescono a essere evocative, complice la lezione dei grandi cantautori come Leonard Cohen, Bob Dylan, Neil Young, su cui si è formato il suo gusto: “Da piccola ascoltavo solo la radio e mi piaceva giocare a calcio. Poi, a quattordici anni, il mio patrigno mi ha insegnato a suonare la chitarra e ho iniziato ad ascoltare questi grandi cantautori che ancora oggi continuo ad amare ”. Salita alla ribalta della scena svedese e internazionale quattro anni fa, Sophie Zelmani ha fatto seguire al suo debutto omonimo, all’insegna della poesia delle piccole cose, l’album “Precious burden” (mai distribuito in Italia) inaspettatamente cupo e drammatico: “E’ stato un periodo in cui tutto andava storto: il successo aveva creato disordine nella mia vita, messo in difficoltà rapporti importanti. ‘Precious burden’ fotografa quel momento. Poi le cose sono andate a posto e oggi ho imparato a convivere con maggiore serenità con quello che il mio essere musicista comporta: cerco, appena posso, di vedere il lato divertente delle cose, di non viverle come un obbligo, come un peso”. “Time to kill” è dunque un album che esprime una conquistata maturità, sia nelle liriche (che spesso trattano del tema del distacco, di un lasciarsi non drammatico ma necessario) che nella musica, complice ancora una volta la collaborazione con Lars Halapi che la accompagna come produttore e chitarrista fin dagli esordi: “Lars mi è indispensabile. Senza di lui non avrei mai potuto fare tutto questo. Per ‘Time to kill’, però, abbiamo deciso di non lavorare da soli ma di circondarci di in una vera e propria band”. Peter Korhonen (batteria), Thomas Axelsson (basso) e Robert Qwarforth (pianoforte), che già avevano suonato con Sophie nel tour seguito al primo disco, sono stati così coinvolti direttamente nella produzione dell’album, registrato in uno studio dell’arcipelago Trosa, in due settimane di ritiro. Il risultato sono undici tracce che fanno trasparire la passione di Sophie per la musica che non ha bisogno di essere urlata, che, priva di orpelli, arrivi dritta al dunque dell’emozione. Oggi Sophie si dice contenta di quello che ha conquistato: “Sono felice del mio successo in Svezia, dei buoni risultati dei miei album in Giappone. Da “Time to kill” non mi aspetto niente altro rispetto a ciò che già ho”. E il mercato americano? “Non mi interessa. Ho fatto promozione negli Usa per il mio primo album. Gli americani vogliono sempre cambiare la tua musica, remixarla. Non mi piace questo loro modo di lavorare”. Serenità, maturità, quanto tutto questo ha a che fare con il fatto di essere diventata mamma? “Etta è nata un anno fa e da quando c’è lei non è che io sia cambiata, semplicemente le cose sono andate al loro posto, tutto ha preso un senso e ho smesso di sentirmi vuota e confusa. Il modo con cui guardo alle cose in fondo non è cambiato: è solo che ora mi sento più solida”.
Schede:
La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale
